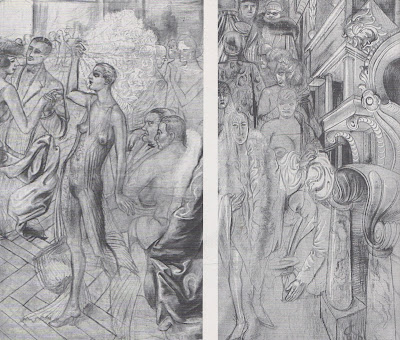Paul Gauguin (1848 -1903), Due tahitiane – 1899, olio su tela, 94 x 72.4 cm – New York, Metropolitan Museum of Art.
ANALISI DELL’OPERA
Due
tahitiane o Due donne tahitiane (Two Tahitian Women) del Metropolitan Museum of Art di New York,
conosciuto anche con un’altra bislacca intitolazione, I seni coi fiori rossi, è stato dipinto nel secondo periodo tahitiano, prima
che Gauguin s’avventurasse alla volta delle isole Marchesi, a 1400 chilometri
da Tahiti.
Si tratta della raffigurazione di due giovani donne
indigene, ritratte fino alle ginocchia, che recano l’una un piatto ricolmo di
frutti maturi, l’altra dei fiori rosa tenuti nelle mani giunte, come nell’atto di
portarli in dono durante un tradizionale rituale a di offrirli a un gradito
ospite. O mostrano soltanto i frutti della natura per impreziosire i loro corpi
seminudi, come se i fiori rosei e le mature bacche vermiglie fossero preziosi
gioielli e, nello stesso tempo, sacri donativi della prodiga madre terra. Delle
due giovani, una occupa quasi il centro del dipinto, ed è ritratta frontalmente,
sia nel corpo che nel viso. Mentre l’altra è disposta sulla desta. Pure il suo
corpo è visto frontalmente, ma col volto raffigurato di tre quarti, in un
sobrio e impercettibile atteggiamento d’intesa con la compagna. Le loro espressioni
sono composte e serene, così come i loro corpi ambrati sono acerbi e statuari
insieme, di una bellezza pura e primitiva, come fossero divinità sacrali
di un mondo mitico e remoto, incorrotto e armonioso, mite e lussureggiante. E
infatti lo sfondo indistinto, alle spalle delle bellissime dee
tahitiane, evoca i colori di una natura incontaminata e di quella terra arcaica
e lontana.
Il dipinto ha un colorismo contenuto ma ben accordato, così come la luce plasma le figure, ben definite da una delicata linea di contorno, con contrasti minimi e un buon effetto plastico, in un complessivo senso di bidimensionalità dell’immagine. Bidimensionalità che non significa piattezza, giacché nei dipinti di Gauguin, vi è sempre una definizione corporea di cose e personaggi, perché la linea di contorno che li circoscrive non annulla mai la percezione del loro volume. Nel dipinto in questione, per esempio, le due figure femminili sono messe in primo piano; lo sfondo costituisce, invece, un secondo piano, privo però di profondità prospettica, dato che in esso si rappresenta molto concettualmente il paradisiaco contesto delle isole oceaniche.
Paul
Gauguin, Manao tupapau (1892), olio su tela, 73x92 cm, Buffalo, Albright-Knox
Art Gallery.
Paul
Gauguin, ... E l'oro dei loro corpi (1901); olio su tela, 67×76 cm, Parigi, Museo
d’Orsay.
La casa
di Gauguin a Tahiti
Paul Gauguin, Autoritratto (1885), olio su tela, 65.2×54.3 cm, Fort Worth, Texas, Kimbell Art Museum.
SULLO STILE DI GAUGUIN
Gauguin intraprende la sua vera strada quando, lasciata Parigi, si reca in Bretagna, dove, a contatto con usi, costumi, gente, panorami severi e solenni, abbandona gradualmente la resa della realtà, per interpretarla liberamente esprimendosi attraverso linee e colori cui attribuisce un valore carico di significati. (...) Ma è soprattutto dal periodo bretone in poi che egli sviluppa sempre più questa concezione, affidandosi in modo particolare alla suggestione della linea e del colore. Si capisce perché apprezzasse e facesse sue, portandole innanzi, le idee del giovane pittore Émile Bernard (1868 – 1941), discutendo con il quale viene scoprendo l’importanza espressiva del colore piatto e del contorno, quasi in una ripresa degli smalti di Limoges, dai colori accostati e contenuti entro una bordatura metallica, la cloison (“divisione”), o delle vetrate medievali, i cui vetri colorati sono sostenuti e separati da quelli adiacenti per mezzo di cornicette di piombo che ne seguono le forme. Questa tecnica, detta cloisonnisme, dà ampia possibilità sia al colore (per la sua purezza non turbata da varianti tonali o chiaroscurali e per la sua prevalenza quantitativa), sia alla linea (per il suo andamento sinuoso), l’uno e l’altra irreali e quindi astratti, di provocare nello spettatore reazioni psicologiche. Piero Adorno
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE:
PIERO
ADORNO, L’arte italiana. Dal Settecento ai nostri giorni, Vol. 3. Casa editrice
G. D’Anna, Messina Firenze,1994.
G. C. ARGAN, Storia dell’arte italiana, Vol. 3°,
1993, Sansoni, Milano.
CRICCO – DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Vol. II,
2012, Zanichelli, Bologna.
AUTORI
VARI, Storia universale dell’arte. Il XX secolo. De Agostini, Novara,1991.
IL POST SOPRA RIPORTATO HA CARATTERE ESCLUSIVAMENTE DIVULGATIVO E DIDATTICO, DESTINATO PERTANTO AGLI STUDENTI E AGLI APPASSIONATI.
© G. LUCIO FRAGNOLI